COP 30: guida ai temi principali
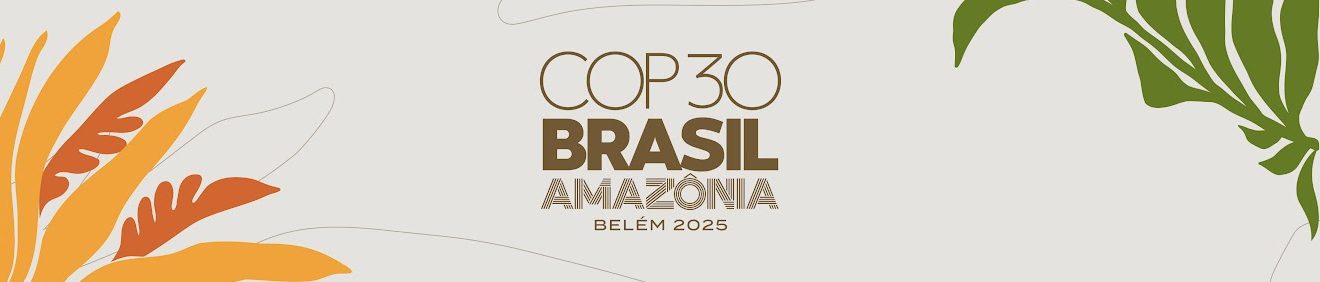
La COP 30 sul clima in programma a Belém, in Brasile, dal 10 al 21 novembre, si aprirà in un contesto geopolitico particolarmente complesso. Nelle lettere inviate ai Paesi, il presidente della Conferenza André Corrêa do Lago – diplomatico di lunga esperienza e attuale Segretario per il Clima, l’Energia e l’Ambiente presso il Ministero degli Esteri brasiliano – ha delineato tre grandi obiettivi di natura politica.
Il primo è riaffermare il ruolo centrale del multilateralismo come via maestra per affrontare la crisi climatica, ribadendo che il meccanismo dell’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) funziona. In particolare, il cosiddetto “ciclo dell’ambizione” – che regola la presentazione, la revisione e il rafforzamento degli NDC, i contributi determinati a livello nazionale – resta un pilastro per incrementare gli impegni di riduzione delle emissioni climalteranti.
Il secondo obiettivo punta a rafforzare il legame tra negoziato e azione concreta, rilanciando la Action Agenda, l’insieme di iniziative parallele ma connesse ai negoziati ufficiali. La presidenza intende aggiornarla alla luce del primo Global Stocktake, approvato a Dubai durante la COP 28, per accelerare l’attuazione delle politiche climatiche. Il Global Stocktake – un inventario quinquennale dei progressi compiuti dagli Stati – ha evidenziato che i Paesi sono ancora lontani dagli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Per mantenere vivo il traguardo di 1,5°C e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, sarà necessario ridurre le emissioni del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035, rispetto ai livelli del 2019.
Il terzo punto riguarda l’attuazione dell’Accordo di Parigi. Dopo la definizione alla COP 29 delle ultime regole sull’articolo 6 relativo ai mercati del carbonio possiamo dire che il libro delle regole stabilite a Parigi è infatti completo.
Sul tema specifico, lo scorso anno è stato lanciato il primo mercato globale del carbonio, destinato a regolamentare l’emissione e lo scambio dei crediti, sotto la supervisione dell’ONU. È in corso la creazione di un registro unico internazionale che raccoglierà progetti legati, per esempio, alla riforestazione e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, consentendo agli Stati e alle imprese di scambiare crediti tra loro. Tuttavia, restano ancora molte criticità da affrontare in termini di trasparenza, efficacia dei progetti finanziati e tutela dei diritti umani.
Cop 30: adattamento e finanza, una sfida aperta
Tra i principali temi negoziali della COP 30 figura l’adattamento, sempre più centrale a causa dell’intensificarsi degli impatti climatici. In questo contesto si inserisce il lancio del Tropical forests forever facility (TFFF), il fondo promosso dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva per la conservazione delle foreste tropicali. Il Brasile ha annunciato un contributo iniziale di circa un miliardo di dollari, mentre Cina, Regno Unito, Francia, Germania, Singapore ed Emirati Arabi Uniti hanno già manifestato sostegno all’iniziativa, aprendo la strada a ulteriori finanziamenti pubblici e privati.
Sempre sul fronte dell’adattamento, i Paesi più vulnerabili – in particolare quelli africani e le piccole isole del Pacifico – chiedono che il tema riceva la stessa attenzione finora riservata alla mitigazione. A Belém sarà infatti necessario chiudere il Global Goal on Adaptation, definendo indicatori chiari e condivisi per misurare i progressi. Se per la mitigazione il monitoraggio è più agevole, grazie ai dati sulle emissioni, valutare l’adattamento è molto più complesso, poiché implica politiche nazionali eterogenee in materia di infrastrutture, nature based solutions, ecc. Alla COP 29 sono stati identificati circa cento indicatori per l’attività di reporting: un pacchetto che dovrà ora essere ridotto e armonizzato.
Il tema è strettamente legato alla finanza climatica. Tra gli indicatori figurano infatti elementi relativi ai “means of implementation” – risorse, partnership e politiche necessarie per attuare i piani di adattamento – che restano oggetto di forti tensioni. La disputa riguarda le risorse effettivamente destinate alle politiche di adattamento, questione che infiamma i negoziati, soprattutto dopo la definizione del nuovo obiettivo quantitativo di finanza climatica (NCQG – New Collective Quantified Goal).
Alla COP 29 di Baku si è deciso di innalzare l’obiettivo di 100 miliardi di dollari annui, stabilito a Copenaghen nel 2009 e confermato a Parigi nel 2015, portandolo a 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035. Una cifra che tuttavia resta lontana dagli 1.300 miliardi ritenuti necessari – una soglia minima – dai Paesi più vulnerabili per sostenere l’adattamento e la transizione energetica verso le fonti rinnovabili.
Rimane inoltre irrisolto il tema dell’equilibrio finanziario tra mitigazione e adattamento. L’obiettivo, mai formalizzato ma spesso evocato dai Paesi vulnerabili, di una ripartizione “50 e 50” non è stato raggiunto, anche perché i progetti di adattamento risultano più difficili da finanziare. Per questo, il Brasile starebbe lavorando a un “pacchetto per l’adattamento”, con l’ipotesi di triplicare i fondi, sebbene non sia ancora stato completato nemmeno il raddoppio stabilito in precedenza.
La “giusta transizione”
Un altro tema in ascesa è la giusta transizione, introdotta formalmente alla COP27 in Egitto. Il suo significato varia a seconda dei Paesi: nell’Accordo di Parigi è legato agli impatti delle politiche climatiche sulla forza lavoro – creazione di posti, riqualificazione professionale, sostegno ai lavoratori – ma per molti Stati, soprattutto emergenti, la “just transition” coincide con una transizione equa in senso più ampio, capace di tenere conto degli ostacoli economici e sociali e di conciliarsi con lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà. La COP di Belèm dovrà dunque decidere la struttura del programma di lavoro sulla giusta transizione, che finora si è sviluppato attraverso tavole rotonde e consultazioni informali.
Il rischio di una “agenda fight”
Il primo ostacolo della COP 30 potrebbe essere l’approvazione della sua agenda di lavoro, ormai sempre più densa e complessa. Finora il Brasile non è riuscito a costruire un consenso sufficiente per scongiurare il rischio di una “agenda fight”, ovvero uno scontro sul programma di lavoro.
I Paesi in via di sviluppo chiedono in particolare di includere tra i temi di discussione il primo comma dell’articolo 9 dell’Accordo di Parigi, che impone ai Paesi sviluppati di fornire risorse finanziarie a quelli in via di sviluppo.
La questione si intreccia con il tema dei contributi determinati a livello nazionale (NDC). Alcuni Paesi, infatti, tendono a condizionare l’attuazione dei propri piani climatici ai finanziamenti esterni, sostenendo che “possono agire solo se arrivano i fondi”.
Cop 30: troppi ritardi sugli NDC
Tutti i Paesi erano chiamati a presentare nuovi NDC in vista della COP 30, ma il synthesis report dell’UNFCCC mostra un quadro troppo parziale. Solo 64 Paesi, poco più di un terzo del totale, hanno infatti aggiornato ufficialmente i propri piani nazionali di riduzione delle emissioni entro la scadenza fissata per fine settembre, poi prorogata.
Secondo il documento, questi 64 piani porterebbero le emissioni globali al 2035 a circa 13 mila miliardi di tonnellate di CO₂, pari a una riduzione del 6% rispetto alle proiezioni al 2030 contenute nei precedenti impegni e del 17% rispetto ai livelli del 2019. Tuttavia, la portata degli aggiornamenti resta modesta, anche perché mancano all’appello i principali emettitori, tra cui gli Stati Uniti – che hanno ritirato il proprio NDC e abbandonato l’Accordo di Parigi –, l’Unione Europea e la Cina.
Va comunque ricordato che, durante il Climate Action Summit di settembre, 100 Paesi – responsabili di circa due terzi delle emissioni globali – hanno annunciato nuovi impegni di riduzione delle emissioni, che dovranno ora tradursi in piani nazionali aggiornati e coerenti con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
Anche il CBAM tra i temi di scontro
Un tema parallelo ai negoziati, ma destinato a suscitare forti discussioni, riguarda le misure unilaterali legate al clima, particolarmente sostenute dall’Unione Europea e contestate da Cina, India, Arabia Saudita e da numerosi Paesi in via di sviluppo. Tra queste spicca il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere introdotto dall’UE per imporre un prezzo sulle emissioni incorporate nei beni importati da Paesi extraeuropei. L’obiettivo è evitare la rilocalizzazione delle emissioni e garantire pari condizioni di concorrenza ai produttori europei.
La Cina accusa l’Europa di protezionismo e di voler penalizzare le esportazioni dei Paesi più poveri, mentre Bruxelles replica che il CBAM non è una misura commerciale, ma uno strumento di politica climatica volto a spingere tutti gli attori economici a ridurre le proprie emissioni. Diversi Stati intendono chiedere di inserire ufficialmente la questione nell’agenda dei negoziati, probabilmente già all’apertura della COP, sebbene l’UE preferisca affrontarla in altre sedi, come l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Per stemperare le tensioni, Bruxelles propone inoltre di abbandonare l’espressione “misure unilaterali”, considerata ostile, sostituendola con la formula più neutra di “climate trade-related measures”.


